La mediazione umanistica-filosofica: un nuovo paradigma di giustizia
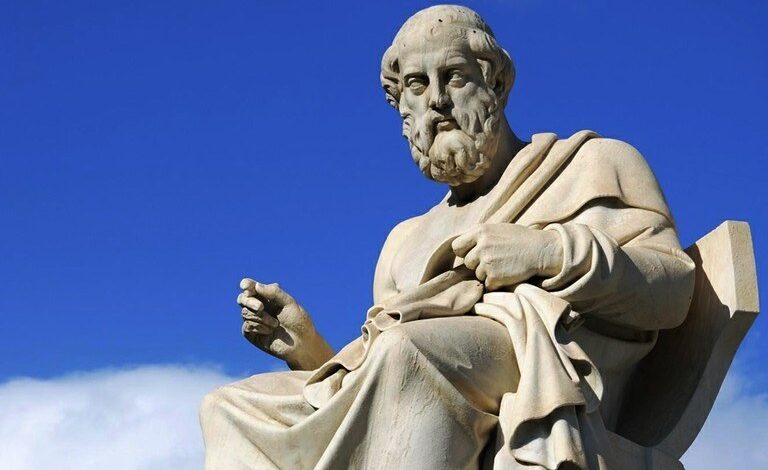
La mediazione umanistica-filosofica rappresenta un paradigma innovativo che va oltre la risoluzione tecnica del conflitto interpersonale, di qualunque natura esso sia, familiare, civile, penale, commerciale, ecc,
Si configura come un viaggio di conoscenza, ascolto e trasformazione. Si tratta infatti di un processo di trasformazione e ricostruzione dei legami umani, fondamentale nelle relazioni interpersonali che sono il cuore pulsante della nostra esistenza.
Infatti spesso attraversate da tensioni e incomprensioni, queste relazioni rompono l’equilibrio emotivo e sociale ed in questo contesto, il conflitto non va visto come un semplice evento da eliminare, ma come una crisi potenzialmente generativa, capace di rivelare ferite profonde, paure e bisogni inespressi.
La mediazione umanistico-filosofica, secondo il modello che ho elaborato,si fonda allora su una comunicazione autentica e fiduciaria, che consente il riconoscimento reciproco attraverso l’ascolto empatico e la valorizzazione delle emozioni e dei vissuti soggettivi. Si impegna a creare uno spazio protetto di dialogo in cui le parti si sentano accolte, condizione essenziale per ricostruire quei legami sociali e personali spesso spezzati dalla sofferenza e dalla sfiducia.
Al centro di questo processo vi è la responsabilità affettiva, intesa come capacità di prendersi cura di sé e dell’altro mediante una gestione consapevole delle emozioni e dei comportamenti. La mediazione umanistico-foilosofica propone una giustizia riparativa, che non si limita a giudicare o punire, ma mira a riattivare la relazione umana e rigenerare la convivenza civile attraverso un percorso di trasformazione personale e collettiva.
Il mediatore, figura chiave, non impone soluzioni, ma accompagna le parti a rintracciare le cause profonde del conflitto e a costruire insieme nuovi equilibri, favorendo un incontro rispettoso e non giudicante. In questo modo, il conflitto si trasforma da frattura a opportunità di crescita, offrendo una prospettiva di speranza e rinascita.
Un esempio può aiutare a comprendere meglio questa pratica: Anna e sua sorella Giulia erano divise da anni da rancori legati all’eredità dei genitori. Ogni tentativo di dialogo diventava un campo di battaglia. Durante il percorso di mediazione, guidate da una mediatrice, sono state invitate non solo a discutere di beni materiali, ma a raccontarsi. Anna ha svelato la paura di essere stata meno amata, Giulia ha ammesso la pressione di sentirsi sempre responsabile. L’ascolto autentico ha permesso di ricostruire il loro legame e il patrimonio è diventato uno strumento per riscrivere il loro rapporto, non più una barriera.
Nel laboratorio della mediazione, le relazioni interpersonali si rimettono in moto. Il conflitto diventa così una crisi generativa, un’occasione preziosa per prendersi cura della responsabilità affettiva: prendersi a cuore il dolore proprio e altrui. Senza fretta e senza giudizio, ciascuno diviene protagonista di una trasformazione personale che rigenera la convivenza civile e sociale.




