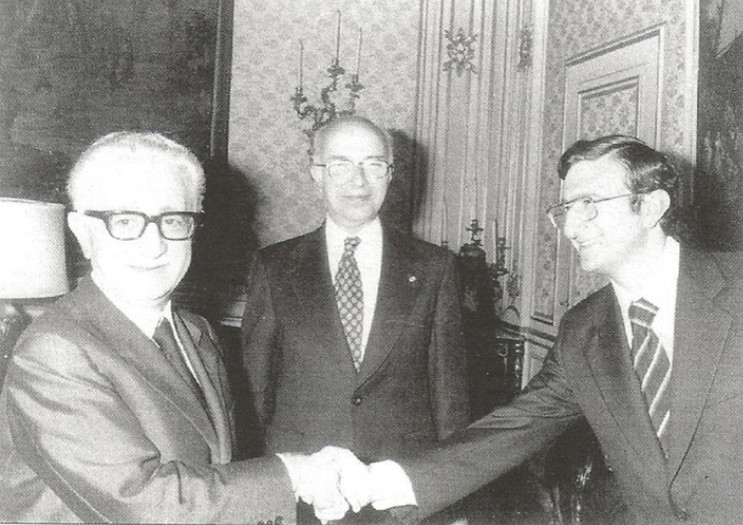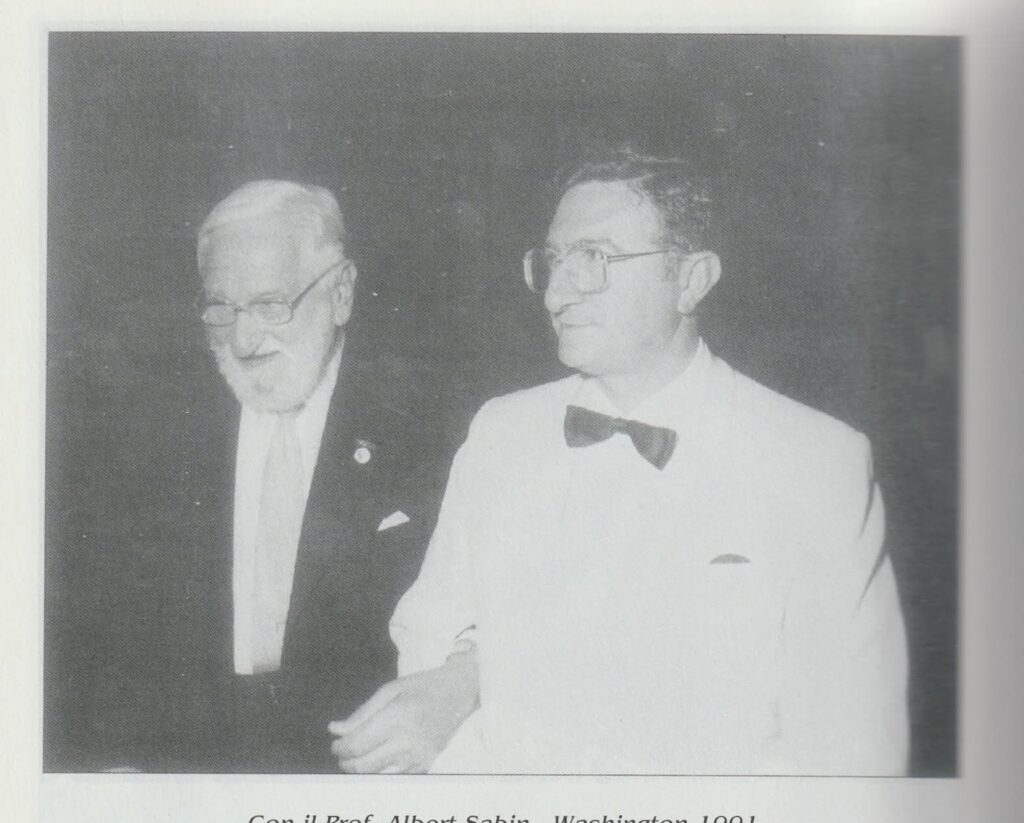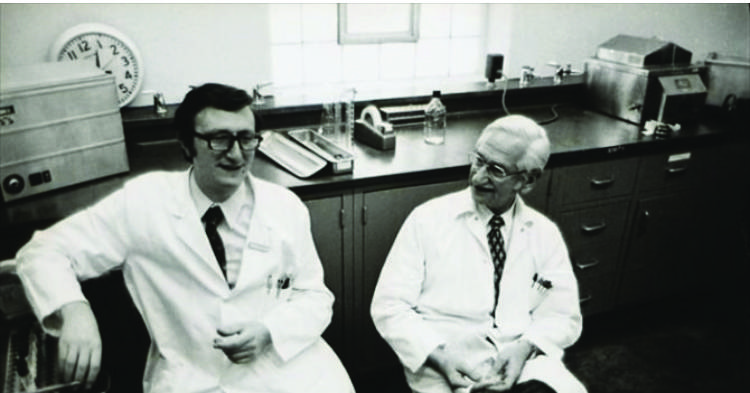Dai microscopi dell’infanzia ai grandi laboratori del mondo: il viaggio di Giulio Tarro

In un’epoca in cui la scienza è spesso al centro del dibattito pubblico, la figura del professor Giulio Tarro continua a far discutere, affascinare, dividere. Virologo di fama internazionale, il professor Tarro ha attraversato oltre mezzo secolo di storia della medicina, contribuendo a momenti decisivi della ricerca sui virus. Allievo di Albert Sabin, il padre del vaccino orale contro la poliomielite, è stato protagonista dell’isolamento del virus responsabile del cosiddetto “male oscuro di Napoli” e dell’isolamento del vibrione del colera, causa dell’emergenza virale del 1973 di Napoli e Bari. Lo scienziato ha attraversato decenni cruciali per la ricerca biomedica, dai primi passi nei laboratori italiani alle esperienze negli Stati Uniti e in Israele, fino all’impegno con la Fondazione De Beaumont Bonelli per le Ricerche Scientifiche, impegnata nel sostegno ai giovani studiosi.
In questa conversazione, Tarro apre lo scrigno dei ricordi: il fascino per il laboratorio coltivato fin da bambino, gli anni a fianco di Sabin, le sfide e le soddisfazioni della ricerca, fino alle passioni personali che lo hanno accompagnato lontano dal camice.
Professore, ci racconta com’era il giovane Giulio Tarro? Da dove nasce la sua vocazione per la medicina e in particolare per la virologia?
Mio padre era un anatomo-patologo, si era laureato con il professor Battaglia, un docente di origini siciliane, e con lui aveva poi conseguito la libera docenza. È stato proprio il professor Pietro Verga, anatomo patologo, a presiedere la mia seduta di laurea a Napoli: un dettaglio che per me ha avuto un grande valore simbolico.
Fin da bambino, però, ho respirato l’aria del laboratorio. Mio padre dirigeva un laboratorio di analisi e la sua unica assistente era mia madre, una preparatrice molto abile. Ricordo che passavo i pomeriggi a curiosare tra vetrini e microscopi: non ho mai pensato a un’altra strada che non fosse la medicina. Anche nella mia famiglia c’erano diversi medici, e così quella scelta mi è sembrata naturale.
Quando iniziai l’università, la virologia era ancora una disciplina agli albori: il professore che teneva il corso dedicava al tema appena due pagine del programma. Poi fu sostituito e il nuovo docente portò la sezione di virologia a quaranta pagine: segno di quanto, in pochi anni, la disciplina stesse crescendo. Questo professore, che aveva acceso in me l’interesse per la virologia, lo ritrovai più tardi alla Cattolica di Roma. Dopo la laurea mi propose di diventare suo assistente, ma declinai per non intralciare il percorso di un amico d’infanzia e collega.
Avevo iniziato gli studi di medicina a Messina, ma all’epoca la città era un po’ carente sul fronte della Clinica medica, che reputavo fondamentale. Così, d’accordo con mio padre, decisi di trasferirmi a Napoli, dove la cattedra di Patologia medica era retta da un grande maestro, Flaviano Magrassi. Mi trasferii al terzo anno e fu una scelta che indirizzò in modo decisivo il mio percorso.
Lei è stato allievo di Albert Sabin, una leggenda della medicina moderna. Quali sono i ricordi più vivi di quell’esperienza e quali insegnamenti ha tratto da lui, sul piano umano e scientifico?
Nel 1960 il vaccino orale di Albert Sabin fu riconosciuto a livello globale per l’eradicazione della poliomielite; nel ’62 era ormai popolare e nel ’63, all’Accademia dei Lincei di Roma, ricevette un premio con un importo superiore al Nobel, la prima volta che accadeva, perché aveva rivoluzionato la vaccinazione introducendo il vaccino orale al posto di quello iniettivo.
Flaviano Magrassi, che conosceva già Sabin, organizzò a Napoli una serata con Roberto Murolo e pochi altri: una decina di persone, tra cui alcuni suoi discepoli, laureati, Sabin ed io, appena laureato.
Due liberi docenti potevano andare a Cincinnati nel laboratorio di Sabin, e alla fine fui scelto io. Mi ero laureato nel dicembre del ’62, ero assistente volontario in patologia medica e, per mantenermi, facevo le guardie sia lì sia in neurologia. Vinsi una borsa di studio intitolata a Sabin, offerta dall’Istituto Sieroterapico Vaccinogeno Toscano Sclavo di Siena: grazie a quella potei partire.
Il 30 agosto del ’65 arrivai a Cincinnati: Sabin venne personalmente a prendermi in aeroporto con una cabriolet e mi portò in un appartamento di fronte al suo centro di ricerca. Era un momento particolare: lui era molto popolare, aveva collaborato con l’Unione Sovietica per la sperimentazione del vaccino e nel suo laboratorio lavoravano anche scienziati “oltre cortina”. Era severo e molti americani non volevano lavorare con lui. Eppure, mi favorì, mi trovò casa e mi accolse nel suo gruppo: dal primo giorno non lo lasciai più.
Rimasi con lui dal ’65 al ’68, poi, dopo tre mesi trascorsi a Napoli, tornai a Cincinnati e rimasi fino al ’70, questa volta con un Grant americano. Dopo il primo anno, quando Sabin cominciò a viaggiare spesso, arrivai a gestire il suo laboratorio: ero il più giovane direttore dell’istituto.
La mattina preparavamo insieme il programma scritto per collaboratori e tecnici. Ricordo che raccoglievo tutti i foglietti con programmi e protocolli del giorno: se qualcosa non fosse andato, Sabin si sarebbe arrabbiato con me. Ma avevo sempre i bigliettini a portata di mano per mostrargli che tutto era in ordine. Ero totalmente dedito al lavoro e quell’esperienza mi ha segnato profondamente, sia come scienziato sia come uomo.
In che modo l’ambiente culturale e scientifico americano ha influito sul suo percorso di ricerca e sulla sua visione della scienza?
Entrare nel laboratorio di Sabin significava trovarsi in un ambiente unico, all’avanguardia. Sabin era famoso non solo per il vaccino, ma anche per il carattere duro: io riuscii, nel giro di un anno, a diventare il responsabile del suo laboratorio. Avevo un buon rapporto con lui e con la segretaria, che sapeva tenergli testa: fu un’esperienza che mi fece crescere molto.
In seguito, Sabin fu chiamato in Israele al prestigioso Istituto Weizmann per le Scienze, uno dei centri di ricerca più importanti del mondo. Andai a trovarlo e vi trascorsi un mese indimenticabile.
All’epoca quel laboratorio era sotto i riflettori: Sabin aveva da poco sperimentato il vaccino antipolio, e io mi trovavo immerso in un ambiente di ricerca straordinariamente innovativo, circondato da una cultura scientifica che per un giovane studioso era fonte di continuo stimolo. Era un vero laboratorio d’elezione, non un ambiente scientifico qualunque. Ricordo che, in quegli anni, a Cincinnati mi capitava di incontrare anche i Beatles: l’America di allora era un centro di fermento culturale e scientifico senza pari.
La sua posizione sui vaccini ha spesso fatto discutere. Cosa pensa del dibattito contemporaneo sulla vaccinazione obbligatoria, anche alla luce della pandemia?
Già il 30 gennaio 2020 avevo pubblicato sul Bollettino Ufficiale dei Biologi e su una importante rivista asiatica considerazioni sul nuovo virus. L’8 marzo, mentre stavo per partire per Israele, fui bloccato in aeroporto a causa delle restrizioni; più tardi, a fine marzo, espressi pubblicamente la mia posizione in televisione da Bruno Vespa: da allora sono stato molto criticato.
Mi ispiravo a ciò che avveniva all’estero, guardavo ai vaccini russi, cinesi o indiani. In Italia, secondo me, si è agito con scelte discutibili: ad esempio, il 27 dicembre 2020 abbiamo vaccinato una giovane dottoressa di 29 anni a Roma, mentre in Inghilterra le prime dosi andavano a ottantenni e persone con gravi patologie, e già il 19 luglio avevano concluso l’obbligo vaccinale.
Io non sono contrario alla vaccinazione obbligatoria, sono stato e resto favorevole ai vaccini per le malattie infettive note, come la poliomielite e il vaiolo. Tuttavia, ritengo che l’obbligo vada applicato con cautela, soprattutto nei confronti di persone con particolari fragilità, come alcuni bambini con lesioni genetiche oggi identificabili. Ci sono situazioni che richiedono valutazioni più attente e personalizzate.
Negli anni Settanta lei si è trovato al centro delle indagini sul cosiddetto “male oscuro di Napoli”. Può raccontarci come visse quella vicenda e come arrivò all’isolamento del virus responsabile?
Fu un’esperienza straordinaria. Era il 6 gennaio 1979: quel giorno, leggendo il giornale, lessi delle misteriose morti infantili attribuite al cosiddetto “male oscuro di Napoli”. Poco dopo mi chiamò il giornalista Willy Molco, che già mi conosceva per il mio lavoro, e mi chiese perché non mi stessi interessando a ciò che accadeva nella mia città. Gli risposi che al Cotugno ci occupavamo di pazienti adulti, non di bambini.
Dopo averlo accompagnato in aeroporto al suo ritorno a Milano, tornai in ospedale e mi misi a rivedere i dati e la casistica: scoprii che al Caldarelli c’erano già stati due casi di “male oscuro” che sembravano legati a una virosi. Mi misi allora in contatto con il direttore sanitario del Santobono, dove erano ricoverati i piccoli pazienti, e andai nella clinica pediatrica.
A una settimana dalla partenza del giornalista riuscì ad ottenere campioni clinici dai bambini intubati e a studiarli in laboratorio. Pochi giorni dopo annunciai di aver isolato il virus respiratorio sinciziale. Molco pubblicò la notizia, e subito dopo anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità confermò i risultati: all’Istituto Superiore di Sanità, vennero mostrati 18 isolamenti del virus, 15 dei quali provenivano dalle mie ricerche. Qualche giorno dopo fui convocato a Napoli: gli esperti dell’OMS vollero vedere di persona il mio laboratorio e vennero al Cotugno, dove osservammo insieme i campioni al microscopio. Al loro rientro, la stampa diede grande risalto al mio lavoro. Per questo ricevetti anche un riconoscimento dalla Cassa di Risparmio di Pistoia: due medaglie d’oro, consegnate dal presidente della Corte costituzionale, Paolo Rossi.
La sua Fondazione “Teresa e Luigi De Beaumont Bonelli per le Ricerche Scientifiche”, svolge un’intensa attività culturale e scientifica. Può raccontarci quando è nata e con quale missione?
Negli anni Settanta fui contattato dalla marchesa Teresa Bergel de Beaumont Bonelli, che desiderava incontrarmi a Roma. Suo marito aveva lasciato un ingente patrimonio, terreni, un castello, altri beni, alla Nobel, a condizione che ne modificasse il nome in suo onore. La Nobel non cambiò nome, ma ebbe comunque una parte del lascito, e la marchesa, rimasta senza figli, decise di destinare il patrimonio a me, essendo io un giovane scienziato già molto noto.
Io le dissi, con franchezza, che non potevo accettare un’eredità personale, ma la invitai a creare una Fondazione dedicata alla ricerca scientifica, che portasse il suo nome. Lei accettò, ma l’iter fu complicato: incontrai molte resistenze e addirittura si persero le carte dell’atto. Dopo giorni di ricerche e colloqui, riuscii a far emergere i documenti smarriti e nel 1973, grazie a una legge specifica del Presidente della Repubblica italiana Giovanni Leone, la Fondazione fu ufficialmente riconosciuta: il presidente dovevo essere io, mentre il consiglio di amministrazione era composto dal prefetto di Napoli, da altri membri della comunità e da due persone di mia fiducia.
La missione della Fondazione è sempre stata quella di sostenere i giovani ricercatori, in particolare offrendo loro opportunità di formazione all’estero. Nel 2020 la Fondazione ha ricevuto un importante riconoscimento: la targa del Presidente della Repubblica, consegnata al Senato, e in quell’occasione pronunciai il discorso conclusivo. Per me è un orgoglio aver trasformato la volontà della marchesa in un’istituzione che guarda al futuro della ricerca attraverso i giovani.
Al di là della medicina, ci sono passioni o interessi personali che la accompagnano da sempre?
Intorno al 1976-77 ho iniziato a dedicarmi, per puro piacere, all’allenamento calcistico. Ho sempre avuto il pallino dello studio, ma il calcio mi ha accompagnato come passione: da adulto mi sono occupato del mio allenamento personale e poi ho fatto parte della squadra dell’ospedale Cotugno, che era davvero competitiva. Abbiamo partecipato a diversi tornei e, ricordo con piacere, vincemmo perfino una partita contro la squadra della banca svizzera UBS.
C’è un aspetto o un aneddoto che riguarda lei o la sua carriera che ritiene sia poco noto e che vorrebbe condividere con i nostri lettori?
Un aspetto poco noto della mia carriera riguarda il mio legame con il servizio militare. Quando ero in America avevo una certa carenza fisica che non mi aveva consentito di prestare servizio militare. Tuttavia, al mio ritorno mi misi a disposizione e feci il giuramento all’Ammiragliato, diventando capitano di corvetta.
Fu un’esperienza molto interessante: successivamente, nel 1984 fui richiamato come capitano di fregata e nel 1990 a Livorno ricevetti la medaglia d’oro dell’Ispettorato della Marina. L’ultimo richiamo avvenne nel 1995, anno in cui entrai anche a far parte del Comitato di Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Proprio in quel periodo, a metà luglio del 1995, mi chiesero un parere sulle vaccinazioni per le truppe italiane che stavano sbarcando in Somalia, durante una mia visita al Ministero della Marina. Consigliai di vaccinare per l’epatite, ma non per la poliomielite con il vaccino Sabin, basando la mia decisione su valutazioni scientifiche e di sicurezza.
A breve verrà pubblicato un libro sulla mia carriera, realizzato da una giornalista e dedicato ai miei nipoti, in cui racconto anche questo episodio.
Qual è il suo consiglio per i giovani che si avvicinano oggi alla medicina o alla ricerca scientifica?
Posso dirlo in base alla mia esperienza: è fondamentale uscire dai propri confini e confrontarsi con altri Paesi. Fare ricerca all’estero permette di crescere, di respirare altre atmosfere scientifiche e di lavorare al di sopra dei condizionamenti politici. Esperienze in centri di eccellenza, anche lontani come in Nuova Zelanda, possono aprire la mente e rafforzare la formazione del ricercatore.
Di recente lei ha pubblicato un articolo sul virus West Nile, che ha destato preoccupazione di recente. Quali aspetti ritiene più rilevanti da sottolineare?
Il virus West Nile non è una malattia nuova: è conosciuto da tempo, anche in Egitto, e collegato alla trasmissione tramite zanzare. Non rappresenta un rischio epidemiologico imminente perché si tratta di un virus già studiato e controllato. È importante distinguere tra allarmismo mediatico e realtà scientifica: la popolazione non deve essere terrorizzata per una malattia di cui sappiamo già gestire diffusione e rischi. Chi ha esperienza con la sorveglianza sanitaria sa che, pur essendo da monitorare, non si tratta di una nuova emergenza.
Dalle aule universitarie di Napoli ai laboratori di Cincinnati, dal fronte della ricerca sui virus emergenti all’impegno per sostenere i giovani scienziati, la vita di Giulio Tarro è stata segnata da passione e dedizione alla scienza.
Un testimone prezioso per i giovani, che invita a mantenere viva la spinta alla ricerca e al pensiero critico, elementi fondamentali per affrontare le sfide della medicina contemporanea e a non fermarsi davanti alle difficoltà, guardando oltre i confini, perché la scienza è fatta di studio, passione e libertà di pensiero.
La voce di Giulio Tarro restituisce l’immagine di un medico e di uno scienziato che ha saputo coniugare rigore e curiosità, radici italiane e apertura internazionale, un uomo che ha sempre guardato oltre i confini, convinto che il progresso scientifico nasca dal confronto, dall’esperienza e dalla curiosità.