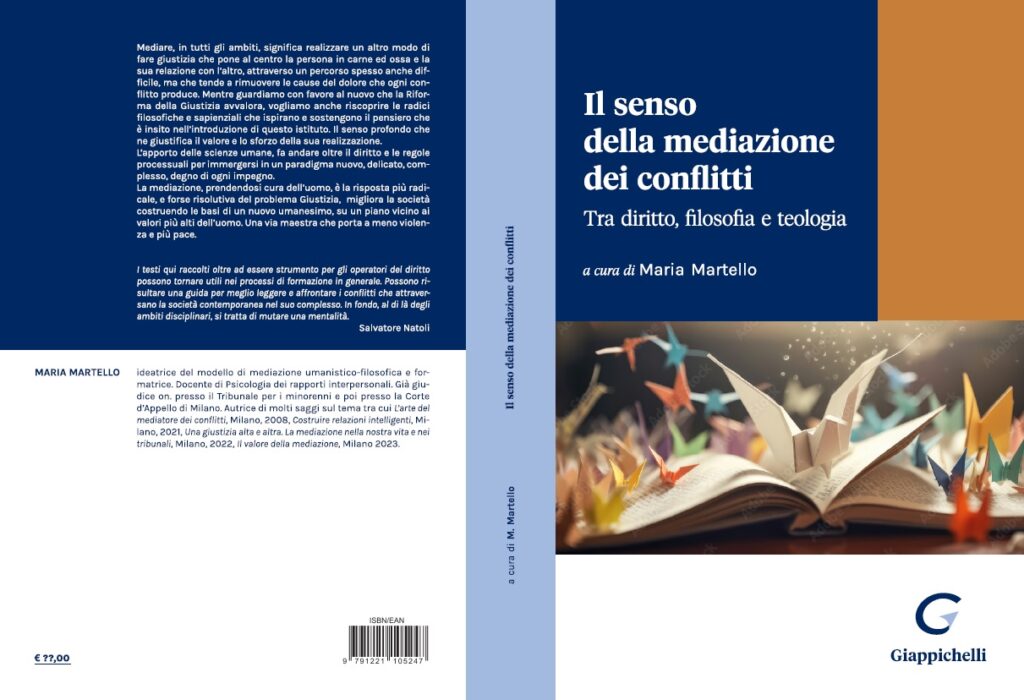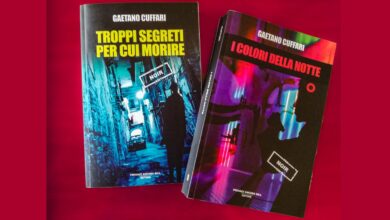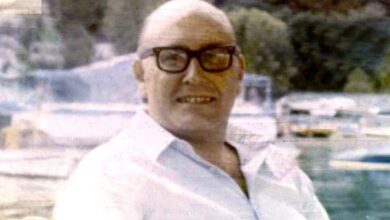Sinfonia per chi non vuole la pace. La mediazione: racconto di una rinascita

C’era una volta, in un tempo non definito, un mare inquieto di parole taciute e mani serrate: era il nostro mondo, dove la guerra, piccola o grande, si insinuava nei cuori come la notte tra i rami spogli. In mezzo a questo oceano, spuntò una nave di carta: fragile, eppure capace di sfidare la tempesta. Su quella nave, una donna di nome Maria Martello raccolse voci sparse, desiderando comporre una sinfonia che parlasse la lingua dimenticata dell’armonia.
Il libro da lei curato, “Il senso della mediazione dei conflitti: tra diritto, filosofia e teologia”, edito recentemente da Giappichelli, non era una semplice raccolta di pensieri: era un canto corale, una promessa di rinascita, un invito a chi, ostinatamente, non voleva ascoltare il richiamo sottile della pace. Il suo scopo? Strappare le radici dei conflitti non per negarle, ma per farne fiorire relazioni nuove, consapevoli e vibranti come pioggia d’estate sulla terra arsa.
Fin dalle prime righe, il lettore veniva cullato tra le onde del coraggio, quello galileiano, che osa alzare lo sguardo anche quando tutto sembra perduto. La mediazione, in questo viaggio, non era stampella ma vela: una via di crescita, di risurrezione, di fiducia ritrovata. Il dolore non era più un macigno, ma una stella polare, e la paura, per chi aveva il cuore aperto, diventava il vento che spinge la nave verso l’incontro.
In questo racconto, il mediatore non era giudice, né arbitro stanco, ma direttore d’orchestra di anime. Di fronte alla rabbia, egli offriva la mitezza; nel silenzio, ascoltava il pianto non detto; nella solitudine, accoglieva con la tenerezza di chi sa che la forza vera è lasciarsi attraversare dall’altro. La sua umiltà era la radice della sua grandezza. Sapeva riconoscere le proprie ombre e danzava tra la luce e il buio, come chi, scalzo, cammina sull’orlo del precipizio e non cade.
Il mediatore era umile e fiero insieme, assertivo senza arroganza. Pensava in modo diverso, come un bambino che costruisce castelli dove gli adulti vedono solo macerie. Sapeva tacere per ascoltare l’anima altrui, cogliendo i bisogni nascosti, i sogni mai confessati, le verità che tremano nel fondo degli occhi. Era, sotto l’armatura della competenza, un esploratore nella giungla dei vissuti, pronto a guidare chi voleva ancora vincere da solo verso la meraviglia del “vincere insieme”.
La sua mitezza non era abbandono, ma forza contagiosa: ammorbidiva la durezza, scioglieva la paura, apriva la strada al perdono. Imparava dai giorni e dalle notti, forgiato in un cammino che non aveva fine. Resistendo alla tentazione di “tagliare il bozzolo” per facilitare la metamorfosi, si faceva custode e non salvatore, compagno e non giudice. Sapeva che solo attraversando il dolore insieme si poteva trovare la farfalla.
Nel cuore di questa narrazione, la giustizia abbandonava la benda sugli occhi e guardava l’altro. Non più solo regola, ma sguardo. Non solo punizione, ma riparazione. Non solo giudizio, ma riconoscimento e abbraccio. Era la giustizia che accoglie, che accarezza le ferite, che ricuce gli strappi della storia. Bartoli ne parlava come un miracolo rivoluzionario: non la legge che separa, ma l’incontro che trasforma la colpa in occasione di crescita, la vittima e l’autore in due esseri umani che si riconoscono e si ascoltano.
Agnese Moro portava, tra queste pagine, il frammento di vita che solo chi ha attraversato il dolore più nero può offrire: la possibilità di parlare al male, di trovare umanità dove sembrava impossibile.
E così anche giudici e avvocati, spaesati e poi illuminati, venivano invitati a cambiare pelle: non più macchinisti di processi, ma artigiani di relazioni; non più guerrieri in tribunale, ma custodi di domande e di perdono. La riforma non era solo legge, ma sogno di una società che non ha paura di guardare in faccia il proprio dolore.
E infine, la mediazione si elevava a lavoro spirituale, viaggio che attraversa il cuore degli uomini e delle donne. Era il sabato ebraico del conflitto: la pausa che rende possibile la rinascita. Tomassone e Bovati ricordavano che la giustizia vera non punisce, salva. Il perdono, settanta volte sette, non è debolezza ma potenza. L’esempio di Giuseppe e quello dei porcospini, la saggezza africana dell’Ubuntu: tutto invitava a vedere negli altri il nostro stesso destino.
Questo racconto, caro lettore o lettrice che ancora temi la pace, non è solo un libro. È un faro acceso nella notte, una mano tesa a chi non vuole cedere. È la memoria di riti antichi, la voce universale della mediazione che, come in una sinfonia, ci invita a ritrovare l’armonia sotto il cielo di tutti e di tutte. È una storia che parla al tuo cuore, per ricordarti che fare pace non è debolezza: è l’eroismo più grande, il dono che ci permette di essere finalmente, profondamente umani.