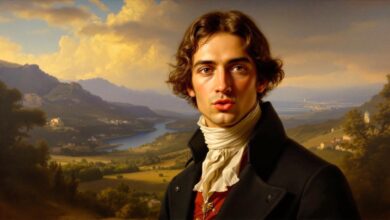Stereotipi e parità di genere. La percezione della competenza femminile nella mentalità collettiva

Ancora oggi i pregiudizi di genere influenzano le valutazioni che studentesse e studenti universitari assegnano ai loro professori e alle loro professoresse. Lo mostrano i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista “Philosophical Psychology”. La ricerca, firmata da Pia Campeggiani (Università di Bologna), Marco Viola (Università Roma Tre) e Marco Marini (Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche), evidenzia che, a parità di contenuto, i docenti uomini vengono percepiti come più chiari, competenti e autorevoli delle colleghe donne, mentre le docenti ottengono punteggi più alti solo su dimensioni stereotipicamente femminili, come quelle associate alla cura.
“Il nostro studio – ha affermato Campeggiani, professoressa del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna – mostra che i pregiudizi di genere sono così radicati da influenzare le valutazioni anche quando si legge o si ascolta lo stesso identico testo, attribuito casualmente a un docente uomo o a una docente donna. Nemmeno i partecipanti con idee progressiste ed egualitarie sono risultati immuni dall’influenza degli stereotipi sulle loro valutazioni: un elemento che evidenzia la natura implicita e pervasiva dei pregiudizi di genere”.
Ma perché è così difficile cambiare la mentalità collettiva?
Nel 1921 Sigmund Freud pubblicava un famoso saggio, destinato ad avere grande fama: “Psicologia delle masse e analisi dell’io”. Secondo Freud cambiare la nostra percezione del mondo è estremamente difficile a causa della natura impulsiva, irrazionale e suggestionabile delle masse, che tendono a resistere al ragionamento complesso e all’autoconsapevolezza. Le dinamiche di gruppo amplificano le emozioni più rozze, rendendo il gruppo suscettibile incapace di cambiare i propri orientamenti in modo stabile e razionale.
Le masse, sostiene Freud, non conoscono la sete della verità; hanno bisogno di illusioni e a queste non possono rinunciare.
Gli esseri umani, in genere, sono per loro natura “conservatori” e cambiano con difficoltà le proprie idee, specie quando queste ultime sono profondamente radicate e traggono la loro origine in secoli di storia condivisa.
Nelle poleis greche alla donna era affidata la cura dell’oikos (che in Grecia non era solo il luogo fisico della casa, ma un’unità sociale, economica e dinamica, che comprendeva familiari e schiavi). Prendersi cura della casa era certamente un ruolo di responsabilità, ma precludeva alle donne ogni forma di partecipazione politica.
Le donne colte nel V secolo a.C. erano in genere le etère, donne di compagnia che potevano anche offrire servizi sessuali. La donna comune, la madre di famiglia, viveva in casa e spesso era priva di cultura.
La visione della donna come portatrice di perdizione è presente nei poemi omerici (alla fuga di Elena con Paride si attribuisce l’origine della guerra di Troia) e nella Teogonia di Esiodo (pensiamo a Pandora che apre il famigerato vaso che contiene tutti i mali). Penelope aspetta per dieci anni il marito con l’unico obiettivo di preservargli il trono dai proci.
Il ruolo riservato alle donne dalle Sacre Scritture non è di certo migliore. Nella Genesi il Signore Dio disse alla donna: “Che hai fatto?”. Rispose la donna: “Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato (la mela)”.
E’ dunque alla tentazione di Eva che dobbiamo la cacciata dal paradiso. Per questo anche nella cultura ebraica e cristiana le donne sono sempre state viste con sospetto e relegate al ruolo di madri e mogli.
Per vedere qualche significativo passo in avanti dobbiamo aspettare in Europa l’Illuminismo (nel 1739 con la pubblicazione del “Newtonianismo per le dame” di Francesco Algarotti, alcune donne europee cominciarono ad interessarsi allo studio delle materie scientifiche, e non più solo di musica e canto) e la Rivoluzione francese con Olympe de Gouge che, nel 1791 rivendicò il diritto di voto per la donna (“la donna ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve avere pure quello di salire sul podio” – articolo 10 della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina).
L’emancipazione femminile procede poi come un gambero: due passi avanti e uno indietro. Indietro durante la Restaurazione, avanti con le suffragette e durante la Grande Guerra (ricordiamo le donne autiste, le donne operaie in fabbrica e le infermiere della Croce Rossa al fronte). Maria Salomea Skłodowska-Curie, prima di vincere i suoi due premi Nobel, dovette trasferirsi a Parigi per poter studiare, perché a Varsavia l’accesso delle donne agli studi superiori non era consentito.
I regimi nazifascisti segnarono in Europa una nuova brusca frenata.
In Italia durante il fascismo le donne furono escluse dalle cattedre di filosofia e da ogni forma di docenza universitaria ed ottennero, come è noto, il diritto di voto solo nel 1946, alla fine della Seconda guerra mondiale.
Se, in estrema sintesi, questo è stato il percorso effettuato dalle donne nella storia occidentale non esitiamo a comprendere perché nella mentalità comune le donne vengano ancora percepite come meno competenti e preparate.
I pregiudizi di genere, infatti, nascono da una serie di aspettative su ruoli, norme e comportamenti associati in modo stereotipico a uomini e donne. Di conseguenza, quando queste aspettative vengono violate – per esempio nel caso di docenti universitarie donne – cambiano anche le valutazioni delle persone.
Per tornare ai dati e alla ricerca, Campeggiani, Viola e Marini hanno analizzato questo fenomeno con due esperimenti a cui hanno partecipato studentesse e studenti di filosofia. Nel primo, è stato chiesto loro di leggere e valutare degli estratti di lezioni. I testi erano sempre gli stessi, ma erano attribuiti ora professori, ora a professoresse. Nel secondo esperimento, invece, gli stessi testi sono stati presentati in versione audio, letti da voci maschili e femminili selezionate in base a caratteristiche percepite come tipiche. “In questo modo – spiega Marini, ricercatore all’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr (Cnr-Istc) – siamo riusciti a isolare l’effetto del genere della docente o del docente, mantenendo identico il contenuto della lezione. La differenza nelle valutazioni non dipendeva quindi da cosa veniva detto, ma da chi le studentesse e gli studenti credevano stesse parlando”.
I risultati del primo esperimento mostrano una significativa presenza di pregiudizi di genere specialmente tra i partecipanti uomini. Gli studenti hanno infatti dato valutazioni migliori ai testi quando questi erano attribuiti a docenti uomini, in particolare per caratteristiche come “chiarezza”, “competenza” e “beneficio in termini di apprendimento”, in linea con gli stereotipi che associano agli uomini posizioni di prestigio intellettuale e autorità accademica. L’unica dimensione che i partecipanti, sia uomini sia donne, hanno valutato in modo più favorevole quando i testi erano attribuiti a docenti donne è quella della “cura”, anche in questo caso in linea con aspettative di genere. Interessante, in questo primo studio, il comportamento delle partecipanti donne, che hanno valutato i testi nello stesso modo sia quando attribuiti a docenti uomini sia quando attribuiti a docenti donne. Tuttavia, rispondendo alla domanda se, alla luce del testo letto, avrebbero seguito un intero corso universitario con quel docente o quella docente, hanno manifestato una forte preferenza nei confronti dei docenti uomini.
Il secondo esperimento ha prodotto risultati ancora più marcati. L’ascolto dei testi in versione audio con voci maschili o femminili ha infatti portato sia gli studenti che le studentesse a valutare i professori uomini in modo più favorevole, sempre con l’unica eccezione della dimensione della “cura”, che ha ottenuto valutazioni più alte per i testi letti da voci femminili.
“Questi risultati – ha concluso Viola, ricercatore all’Università Roma Tre – ci invitano a riflettere con attenzione su quanto le valutazioni didattiche rispecchino davvero la qualità dell’insegnamento. E questo vale non solo per i questionari formali, ma in generale ogni volta che si giudica l’operato di una docente o di un docente”.
E più in generale, aggiungiamo, quando si giudica l’operato di una donna che ha raggiunto una posizione apicale e di comando.