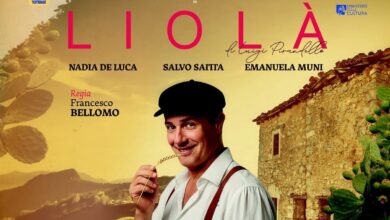L’opera buffa recuperata: Il “Don Pasquale” di Donizetti al ‘Bellini’

È in scena al Teatro Massimo ‘Bellini’ l’opera buffa di Donizetti: Don Pasquale. Musica di Gaetano Donizetti. Dramma buffo in tre atti, su libretto di Giovanni Ruffini. Direttore Riccardo Bisatti. Regia di Ugo Gregoretti ripresa da Giandomenico Vaccari. Scene e costumi Eugenio Guglielminetti. Maestro del coro Luigi Petrozziello. Luci: Gaetano La Mela. Direttore Allestimenti Scenici: Arcangelo Mazza. Allestimento del Teatro Regio di Torino.
Interpreti: Don Pasquale: Dario Russo, Ernesto: Jack Swanson, Norina: Marina Monzò, Dottor Malatesta: Nikolai Zemlianskikh, Un notaro: Dario Giorgelè. Orchestra, Coro e Tecnici del Teatro Bellini.
L’opera buffa, il melodramma giocoso come quello di stasera, è una filiazione, è noto, dell’opera seria – musica d’élite riservata alle corti – che raccoglieva l’eredità della tragedia classica e del teatro rinascimentale.
Questo tipo di composizione creato a Firenze dalla Camerata dei Bardi, già alla sua nascita, tra Cinque e Seicento, aveva acceso una vivace ‘querelle’ circa la supremazia dei suoi elementi: serio e faceto, canto e recitazione. Solo nel XVIII secolo con la riforma di Apostolo Zeno e Metastasio, e poi di Gluck, si stabilirono canoni formali.
L’esclusione dell’elemento comico dal teatro musicale serio e le istanze illuministiche di apertura a un pubblico più vasto determineranno la nascita dell’opera buffa, dapprima in forma di intermezzi che venivano eseguiti negli intervalli: vere e proprie “commedie per musica”.
Fu Carlo Goldoni a mettere in scena dal 1748 il dramma giocoso caratterizzato da una trama sentimentale o patetica ma con un lieto fine.
Mozart sviluppò le suggestioni goldoniane scatenando in Francia la ‘querelle des bouffons’ dopo la rappresentazione de ‘La serva padrona’ di Pergolesi: un intermezzo preceduto dal ‘Trionfo dell’onore’ di Scarlatti.
Saranno Rossini e Donizetti che, attenuando la distinzione tra i due generi e superando la retorica, segneranno il trionfo dell’opera buffa che si era sviluppata tra Napoli, Roma e Venezia.
Da quest’ultimo tipo di spettacolo -tra musica, canto e recitativo- avrebbe preso vita in seguito l’operetta con l’accentuazione dell’elemento coreografico e, in tempi più vicini, il varietà e il musical.
Dopo il compositore pesarese, la musica romantica e quella verista -eliminando il recitativo- apriranno la strada al bel canto, alla lirica pienamente ottocentesca.
L’ultima rivoluzione, quella di Wagner, con i suoi temi conduttori in chiave sinfonica, e il modello teatrale drammaturgico di Verdi influenzeranno infine la ‘Giovane Scuola’ (Leoncavallo, Giordano, Cilea, Puccini).
Nella prima metà dell’Ottocento tre compositori dominavano l’opera italiana: Donizetti, Vincenzo Bellini e Rossini che fu sempre amico sincero e sostenitore degli altri due.
Bellini in una lettera scriveva che la protezione di Rossini gli stava dando gloria e fama. Dopo un primo momento di ammirazione, invece, non risparmiò pesanti critiche a Donizetti, a fronte della grande stima che Gaetano nutriva per lui: lo raccomandò addirittura a Metternich invitandolo a chiamarlo a Vienna.
È in tale contesto che si inserisce dunque Gaetano Donizetti (1797 – 1848) con le sue circa 70 opere composte, segnando il passaggio dal romanticismo del secondo Rossini a quello appassionato di Verdi in tempi brevissimi tra diverse sventure e numerosi lutti che costellarono la sua vita, fino alla malattia mentale, causata dalla sifilide, che lo condusse -cinquantenne- alla morte (“Senza padre, senza madre, senza moglie, senza figli… per chi lavoro… dunque? … Tutto, tutto ho perduto”?”).
Felix Mendelssohn scriveva di lui: “Donizetti finisce un’opera in dieci giorni…qualche volta arriva a dedicare tre settimane”, Un turbinio che lo spingeva a superare le sue umili origini componendo e spostandosi tra Bologna, Vienna, Parigi e Napoli dove fu direttore del ‘S.Carlo’.
L’opera di stasera, il Don Pasquale, la prima opera buffa in cui non sono presenti recitativi secchi ma solo accompagnati fu composta tra novembre e dicembre del 1842 -su libretto firmato da Michele Accursi, ma in realtà di Giovanni Ruffini e dello stesso Donizetti- e messa in scena già il 3 gennaio del ’43 al Thèatre des Italien di Parigi e al Teatro alla Scala dove avvenne la prima esecuzione italiana. La fonte letteraria era tratta da Ser Marcantonio di Angelo Anelli, musicato da Stefano Pavesi Il librettista del Don Pasquale fu invece, si è detto, Giovanni Ruffini, che intervenne quando il musicista era ormai giunto al culmine della celebrità: tra il 1822 e il 1837 aveva composto Lucia di Lammermoor e Roberto Devereux, e tra il 1840 e il ’43 altre opere di minor successo: La Fille du régiment, Les Martyrs, la Favorita e Don Pasquale, composta in soli undici giorni.
Tipica del Don Pasquale è l’amalgama tra lirismo, malinconia e sorriso malizioso o addirittura aperta risata.
Parafrasando la commedia dell’arte possiamo anche ritrovarvi alcune delle sue figure.
Nei panni di Don Pasquale, una sorta di ‘Pantalone’, troviamo Dario Russo che definisce l’opera molto particolare: un’opera buffa con elementi sentimentali e patetici che bisogna saper far risaltare con i loro vari livelli. Dichiara inoltre, nell’intervista rilasciata al nostro giornale la sua difficoltà nell’affrontare Donizetti provenendo da Verdi e Bellini: l’opera buffa non rientrava nel suo repertorio. Il rapporto con il regista – conclude- è stato notevole e proficuo sotto ogni punto di vista, esaltando i tempi e le motivazioni che legano i vari personaggi e creando così un bellissimo lavoro di squadra.
La trama dell’opera è nota.
Don Pasquale, un vecchio avaro, incallito scapolo, vuole obbligare il suo unico erede Ernesto a sposare una ricca ‘zitella’. Ma il nipote è innamorato della vedova Norina, bella ma di umili condizioni. Di fronte a questa realtà lo zio decide, pur di non perdere l’eredità, di sposarsi egli stesso con l’aiuto del dottor Malatesta.
Da qui parte un gioco di equivoci e scambi di persona che ruota attorno a un falso matrimonio con Sofronia/Norina, all’insaputa di Ernesto che, disperato, fugge.
Don Pasquale, gabbato, firma un contratto di nozze con il quale dona alla ragazza la metà dei suoi beni. Ma, appena firmato il contratto, Norina diventa arrogante, spadroneggia sperperando il denaro in feste, sarti e gioielli, rifiutando le avances del disperato marito e facendogli credere di avere un amante.
Avvertito da Malatesta, Enrico si cala nei panni dello spasimante esibendosi, nel giardino di casa, in un duetto d’amore. Da qui si susseguono accuse, rivelazioni e minacce fino all’inevitabile ‘lieto fine’: Don Pasquale, ben contento di essersi liberato della terribile finta moglie, perdona tutti e benedice le nozze fra Ernesto e Norina
Molti sono i motivi d’interesse per quest’opera che Donizetti scriveva dopo aver raggiunto la perfezione nell’opera seria con Lucia di Lammermoor, e dopo aver rivoluzionato l’opera buffa con l’Elisir d’amore con cui si affermava l’opera semiseria caratterizzata da un diverso sguardo sulle vicende umane, dal cambio delle epoche con una riflessione sulla vecchiaia e i suoi lati negativi.
E c’è anche il passare del tempo, il cambiamento delle epoche.
Basti pensare alla scena dello schiaffo quando Sofronia/ Norina rivendica la propria autonomia o, al preludio del secondo atto con l’assolo di tromba che introduce il tema triste dell’aria di Ernesto “Cercherò lontana terra”.
Tutti i personaggi sono tipi classici della commedia cinquecentesca: il basso gabbato, il soprano primadonna, il tenore innamorato, il baritono imbroglione. Don Pasquale è un capolavoro della grande tradizione buffa italiana, la commedia borghese romanticamente lirica ed è anche uno dei pochi titoli donizettiani rimasti in modo permanente nella programmazione di tutti i teatri del mondo.
Ugo Gregoretti, oggi ripreso da Giandomenico Vaccari aveva ambientato la vicenda nella Roma del diciannovesimo secolo servendosi delle illustrazioni realizzate da Antoine-Jean-Baptiste Thomas e raccolte nell’opera Un an à Rome et dans ses environs.
A questo proposito il regista Gian Domenico Vaccari ribadisce che i suo è un allestimento nato negli anni ’80, ’90 del secolo scorso al Regio di Torino e che porta appunto la firma di Ugo Gregoretti, grande uomo di teatro, cinema ma con un’innovazione particolare: non ambientare l’azione in un salotto di ½ Ottocento, ma all’esterno, in un sobborgo caratterizzato da un fiume con una barca e una casa con personaggi in ‘controcampo’ che appaiono e scompaiono e una grande luna: una magia. È un bell’esperimento -conclude Vaccari- dare ad un regista un’opera allestita 30 o 40 anni fa con il compito di continuarla nel tempo.
Anche il direttore d’orchestra dichiara la sua emozione nel dover affrontare per la prima volta quest’opera da lui tanto amata, composta da un autore che egli definisce un genio, un innovatore che apre la via a Verdi…una partitura complessa con recitativi accompagnati dall’orchestra. Il nostro lavoro -ribadisce- è riportare, insieme al regista, quanto è ideato dall’autore.
Un lavoro dunque ben costruito, una messa in scena significativa un’orchestra in perfetta sintonia (anche se a volte sovrastante) con i protagonisti, un ottimo soprano hanno deliziato un pubblico che ha mostrato il suo consenso con meritati applausi.